Staffetta? Attenti a quei due: il Quirinale non sopporta il potere diviso a metà


Una poltrona per due: come ci si sta? Uno per volta, naturalmente. Basta avere pazienza, lungimiranza e tanta, tanta fortuna. Quella necessaria ad allearsi con chi non ti fa fuori prima del tempo.
Il 2, del resto, è numero imperfetto, posto com’è tra l’1 ed il 3 che sono l’unità e la perfezione. Figlio di un dio minore, sull’Olimpo come in politica. Mai fidarsi troppo del 2, quando di mezzo c’è quella cosa al tempo stesso angelica e demoniaca che è il potere. Funziona, ma di rado. Più spesso è letale, soprattutto se c’è di mezzo il Quirinale: colle eterno quanto è eterna Roma ma eternamente refrattario alle diarchie. Salvini e Di Maio sono avvertiti.

È vero: sulla cima della salita di Montecavallo, come i plebei hanno chiamato per secoli il Colle per eccellenza, il due, la coppia è eroicamente rappresentata dai Dioscuri, fratelli immortali ascesi al cielo e raffigurati nel marmo candido mentre domano i loro cavalli. Provengono dalle sottostanti Terme di Costantino, fatte edificare dall’imperatore che poco tempo prima aveva eliminato a Ponte Milvio il suo alter ego, l’altra metà di un impero che avrebbero dovuto governare insieme come due teste dello stesso corpo.

Costantino liquidò Massenzio, e restò solo. Le sue terme sorsero accanto ad un tempio dedicato ad Iside, anch’esso conservatore di memorie fratricide.
Per rendersi conto di quanto fosse imponente il Tempio di Iside-Serapide sul Quirinale si consideri che la sua scalinata d’accesso adesso porta, lungo le pendici del Campidoglio, a Santa Maria in Aracoeli. Le ultime ricerche archeologiche hanno rivelato che a costruirlo furono due fratelli, associati nell’impero per volere del padre Settimio Severo.

Erano Geta e Caracalla, ed i loro nomi vennero scolpiti nel marmo di Carrara su blocchi pesanti tonnellate. Ma poi il secondo fece uccidere il primo che cercava rifugio nelle mani della madre, e restò a godersi in perfetto solipsismo la terribile solitudine imperiale. Il nome di Geta finì scalpellato via, damnatio memoriae suprema, nascosto alla vista degli adoratori di Serapide.
Non sopporta le diarchie e la spartizione dei compiti tra gemelli siamesi, il Quirinale. Non l’ha mai fatto. Fin dagli albori della sua esistenza, da quando cioè sul suo cucuzzolo si stabilì Tito Tazio, re dei Sabini e vendicatore delle sue donne vittime del ratto. Fu a un passo dal fare piazza pulita di Romolo e dei suoi gaglioffi; era riuscito addirittura a prendere tutta Roma a parte il Campidoglio.
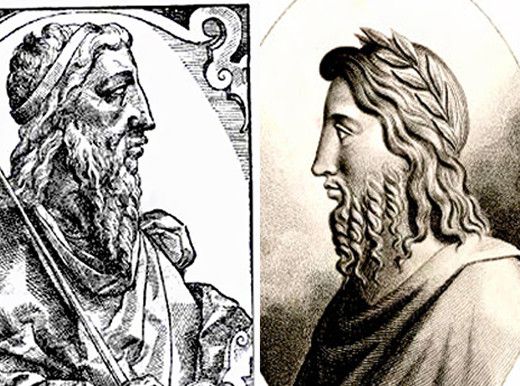
Intervennero però le donne divenute madri dei futuri romani conquistatori del mondo, chiesero e ottennero pace e fratellanza. Si stabilì l’unione dei due popoli e un’opportuna condivisione della monarchia: Romolo e Tito Tazio avrebbero regnato insieme, uno dal Palatino l’altro dal Quirinale. Durò pochi mesi: il sabino finì male, e persino Tito Livio raccolse le voci di un assassinio politico il cui mandante era facilmente identificabile. Del resto Romolo aveva già eliminato un fratello, qualche tempo prima.
I papi, per questi motivi, una volta messi gli occhi sul Quirinale pensarono bene di tenersi separati da se stessi. Un conto è il Papa Re, un altro il Vicario di Cristo. Scissero opportunamente il doppio incarico, che avrebbe sicuramente portato ad un cortocircuito, anche dal punto di vista geografico. Il Vicario di Cristo fu definitivamente messo a dimora da Niccolò V Colonna in quel del Vaticano; il pontefice monarca piazzato da Sisto V Peretti dall’altra parte della città, sul suo colle più alto.

Non una poltrona per due, ma due troni per una persona sola. Il capo della cristianità officiava e canonizzava sulla tomba dell’Apostolo, il sovrano temporale lanciava i suoi decreti e riceveva gli ambasciatori sulla riva opposta, a chilometri di distanza, a Palazzo. E questa volta funzionò almeno qualche secolo.
Non è un caso, allora, che il motto dei Savoia fosse “in famiglia si governa uno alla volta”. Grande saggezza. Solo che la diarchia piombò loro addosso nella persona del Duce condottiero. Il quale dette a Vittorio Emanuele III il titolo di Imperatore, come ai tempi di Geta e Caracalla, ma tenne per sé il potere, facendo sostituire la Marcia Reale con Giovinezza. Non risiedeva sul Quirinale, Mussolini, ma alle sue pendici, in piazza Venezia.

L’incompatibilità scattò inesorabile, e portò alla partenza di un’ambulanza scortata dai carabinieri agli ordini del Tenente Frignani.
Un precedente che qualcuno, perfidamente, evocò quando nel dicembre 1994 crollò il primo governo Berlusconi, sciagura la cui responsabilità l’allora Cavaliere addossò all’allora inquilino del Quirinale, Oscar Luigi Scalfaro.

Bisogna, per correttezza, ricordare che Scalfaro ribatteva alle accuse sottolineando un dato oggettivo, e cioè che l’esecutivo era caduto perché Bossi e Buttiglione non lo sostenevano più (erano i tempi di Berluskaiser, per il leader leghista). Ma pare che, durante un ultimo quanto burrascoso incontro tra i due presidenti, Berlusconi protestasse anche perché aveva pagato di tasca sua la parziale ristrutturazione dell’appartamento del premier, a Palazzo Chigi. E che Scalfaro rispondesse: “Ci metteremo una targa di ringraziamento”.
In realtà la Repubblica aveva già sperimentato una situazione assimilabile alla diarchia. Questa volta lontana dal Quirinale. Correva l’anno 1983: in Italia sorgeva l’astro di Bettino Craxi, troppo debole per governare da solo: aveva il 15 percento dei voti. La Democrazia Cristiana di Ciriaco De Mita era al 38 percento, e da sola non ce la faceva nemmeno lei (situazione che oggi suona familiare, non c’è che dire).

Ricorderà anni dopo De Mita: ''Ci incontrammo in un convento di suore sull'Appia Antica. Proposi a Craxi di guidare il governo perché era l'unico compromesso possibile. Lui fu stupito dell'offerta. E allora rilanciò: metà del tempo a me, metà a te''.
Mai fidarsi dei giovani politici in cerca di affermazione: Craxi restò a Palazzo Chigi da allora al 1987, De Mita dovette sloggiarlo con le cannonate e poi, quando arrivò lui alla Presidenza del Consiglio di anni ne erano passati sei. La formula si chiamava “staffetta”, neologismo politichese che i giornali americani stentarono a tradurre in inglese per i loro lettori, ripiegando su una circonlocuzione presto caduta nell’oblio: “Passing-the-baton”.
Insomma, il potere è divisibile per due? Sempre loro, i Romani, dissero di sì. Prima era di uno solo, il Re, ma poi scrive Eutropio che “ebbero inizio di consoli, che furono due di modo che, se uno di loro fosse stato intenzionato a danneggiare lo Stato, l’altro lo bloccasse essendo titolare degli stessi poteri” (“Hinc consules coepere …”). Il consolato come rimedio, nel nome della separazione dei poteri.
La realtà è che anche il consolato non funzionava sempre. Anzi, portò almeno una volta molto vicino alla fine di tutto: dello Stato, della grandezza, dell’esistenza stessa di Roma. Era il 216 avanti Cristo, e due consoli si alternavano un giorno per uno nel comando dell’esercito spedito al sud per contrastare il pericolo mortale di Annibale. Uno, Emilio Paolo, era per adottare una tattica attendistica, per logorare il nemico e colpirlo quando sarebbe stato sufficientemente indebolito. Era uomo della vecchia aristocrazia senatoria, abituata a ponderare bene le mosse e le decisioni. Ma l’altro era figlio dei tempi: impaziente, decisionista, pronto ad appellarsi al popolo. Ed affamato di gloria e di potere.

Gaio Terenzio Varrone viene indicato dalla storiografia contemporanea come il prototipo del politico populista che si sarebbe imposto nel secolo successivo. Attese che toccasse a lui la giornata di comando, ed attaccò senza pensarci troppo. La carica fu data una mattina, sulla piana di Canne.

Polibio ci racconta che, tempo pochi mesi, Annibale in persona arrivò fino a Roma, e l’Urbe quel giorno sentì sulla sua faccia il pesante alito della morte. Un particolare importante: il cartaginese si presentò alle mura della Città all’altezza di Porta Collina, vale a dire dal lato del Quirinale. Sarà forse per questo che da quelle parti non sopportano le diarchie.