Se questo è davvero il migliore dei mondi possibili, perché siamo così infelici? Un reportage dal TED 2018


“Professor Pinker! Professor Pinker, ci dica: ma se il mondo non è mai stato così bene, come affermano i suoi dati, allora perché sembriamo tutti così infelici?”.
La domanda, così, piatta, è rimbalzata nella grande sala dove due giorni prima il grande studioso di Harvard aveva svolto il suo intervento, ed è diventata un passaparola tra i capannelli di persone nella pausa caffé, spesso accompagnata da una risatina vendicativa, “mai stato così bene? Lui forse…”:
E poi è uscita da lì, l’avveniristico centro congressi di Vancouver, affacciato sull’Oceano Pacifico, per entrare nella rete globale, rilanciata persino dal profilo ufficiale di Twitter dell’evento. “Perché sembriamo infelici, professore?”.

Steven Pinker in quel momento non c’era, l’avrei notato. Si sedeva sempre sul lato destro del teatro, in uno dei posti vicino alle scale per avere più libertà di movimento credo.
E poi nonostante il rango e il prestigio indiscussi, ha il vezzo di indossare camicie di un colore solo, ma sgargiante e sempre diverso, una scelta che sul corpo lungo e dinoccolato che si ritrova a 64 anni, lo fa sembrare una rockstar. Infine i capelli: qualcuno dice che ricorda Albert Einstein, con la sua inconfondibile chioma da leone bianco.
Anche Pinker ha i capelli bianchi in effetti, ma i suoi formano degli strani boccoli che gli scendono fino alle spalle. E così assomiglia, involontariamente immagino, a certi personaggi del suo secolo preferito, il 700, il secolo dei lumi. In quel tempo, quelli come lui li avrebbero chiamati “i parrucconi”, ma “i parrucconi” erano nemici del progresso, Pinker invece lo vede ovunque. E poi i capelli del prof sono autentici.
E comunque non c’era Pinker in quel momento al TED, non c’era quando uno dei presenti è salito sul palco nello spazio che la scaletta tradizionalmente dedica a brevi repliche del pubblico, si è messo al centro del tappeto rosso circolare che è un tratto di fabbrica dell’evento, e ha fatto la domanda del momento: “Perché sembriamo tutti così infelici?”.

Strano sentirlo dire al TED. In quello che per anni è stato considerato il club degli ottimisti. La conferenza, anzi la comunità di quelli convinti che il mondo possa cambiare e diventare migliore grazie alla forza di una idea; e che questa idea possa essere l’idea di ciascuno di noi; ma quelli che sanno anche che per diventare reale quell’idea ha bisogno di essere condivisa, raccontata, supportata.
È una vecchia storia, sintetizzata in un proverbio africano e ripetuta da intere legioni di politici: “Finché sogni da solo è solo un sogno, ma se sogniamo insieme è una rivoluzione”. Qui al TED i sognatori da sempre abbondano, ma questa volta, per la prima volta, molti sembrava che avessero fatto un brutto sogno. Anzi due. E se il mondo non fosse migliore di prima? E se non fosse vero che possiamo migliorarlo così facilmente?
Prima di provare a capire dove sono finiti gli ottimisti e dove è finita la nostra felicità e se le due scomparse sono in qualche modo legate, vorrei dire ancora due parole sul TED.
Perché se c’è un luogo, un evento, un format che in questi anni ha rappresentato il positivismo, la convinzione del progresso umano, la fede nella scienza, ma soprattutto la forza della rete, quel luogo è il TED che è nato come una conferenza qualunque in California, 34 anni fa, con l’idea di mettere assieme una volta l’anno un po’ di gente di Hollywood, un po’ di Silicon Valley e qualche hippie californiano, ed è diventato un movimento globale verso il progresso sostenibile e inclusivo.
Questo è accaduto da quando il timone lo ha preso un giornalista britannico, Chris Anderson, figlio di un oculista impegnato in zone di guerra in paesi lontani e quindi cresciuto con una sensibilità fuori del comune per certi argomenti: ha visto fin da piccolo che il mondo non era solo quello dei ricchi e felici.

Ad Anderson si devono le due intuizioni che hanno fatto del TED quello che è adesso: niente interviste sul palco ma solo interventi in prima persona di 18 minuti (il famoso personal storytelling alla massima potenza); e poi il video di ogni singolo intervento, di ciascun talk, finisce subito sul web dove tutti possono vederlo e diffonderlo facendolo diventare “conversazione globale”.
Infatti “Ideas worth spreading, idee meritevoli di essere diffuse” è lo storico motto del TED, mai cambiato. E mentre col tempo i minuti da 18 sono passati a 9 (solo quelli bravi ne hanno ancora 12, in qualche rarissimo caso 15), il format è essenzialmente lo stesso con un mix che si ripete ogni anno e che assomiglia a quello di certi cocktail di successo che non ti stancano mai.

La formula di un TED perfetto la possiamo sintetizzare così: un po’ di ricercatori di frontiera, soprattutto del MIT e di Stanford, qualche pioniere digitale, diversi esploratori, un grande vecchio (questa volta la parte l’ha recitata da par suo un grandissimo, ieratico, Renzo Piano), diversi ragazzini apparentemente geniali, un paio di cinesi ma aperti al resto del mondo, una manciata di attivisti dei diritti umani, qualche artista (il massimo è quanto ti capita una violinista pazzesca che è anche un’attivista di Amnesty come questa volta Lili Haydin); a volte un mago ma tecnologico, e infine, sempre, un comico intelligente per spezzare il ritmo. Shakerare bene e servire freddo in cinque giornate di fila, all’inizio di aprile e il successo è assicurato.

Da cinque anni il TED ha lasciato l’amata California ed è approdato a Vancouver dove resterà almeno fino al 2023. Non ho capito le ragioni di questo trasloco verso nord finché non sono arrivato qui, nella Columbia Britannica, estremo Canada Orientale. Intanto va detto che Vancouver ha lo stesso fuso orario di San Francisco, Los Angeles e Seattle, tre città da cui vengono molti membri della community.
Per loro questa è una piacevole gita fuoriporta. E poi Vancouver è una città dove tutto funziona alla perfezione: da tre anni finisce nei primi tre posti della classifica mondiale delle città con la migliore qualità della vita, traffico, rifiuti, criminalità qui non sono un problema, passeggi e ti sembra di stare nel parco tematico della città perfetta. Per dire, l’aeroporto da nove anni vince il titolo di migliore aeroporto dell’America Settentrionale (da nessuna parte nel mondo ci ho messo così poco a fare check-in, svolgere i controlli doganali e recuperare bagaglio). Sì certo, piove.
A Vancouver, che è affacciata sull’Oceano Pacifico, piove spesso. Questi giorni non ha smesso quasi mai al punto che una simpatica professoressa del MIT, Penny Chisholm, nel pieno del suo fondamentale intervento su dei misteriosi microorganismi che vivono negli oceani e che lei studia da una vita perché, naturalmente, potrebbero salvare il mondo, si è interrotta per dire questa grandissima verità: “A Vancouver non ti serve una app per sapere che tempo fa. A Vancouver ti serve un ombrello”.

Pioggia a parte, Vancouver è accogliente come pochi altri posti. E ha un centro congressi coi fiocchi che il TED affitta e occupa in ogni singola stanza (in quelle al terzo e ultimo piano ho scoperto che fanno lezioni di wellness e fitness al mattino presto, per esempio). Qui Chris Anderson ha fatto un autentico colpo di genio: smontare la classica, tradizionale, ingessata sala congressi per farsi fare un teatro su misura, su misura del TED. Non tanto e non solo in termini di capienza, è molto grande, ci staranno tremila persone; ma in termini di formato. È andato da David Rockwell, l’architetto che fa le scenografie degli Oscar, e si è fatto progettare il primo maxi-teatro per il personal storytelling.

Anderson infatti è convinto che il format del TED derivi praticamente dagli albori dell’umanità, da quando gli uomini e le donne la sera uscivano dalla rispettive tende e si riunivano attorno al fuoco per raccontarsi delle storie. Anderson sognava un teatro che riproducesse quel meccanismo ancestrale del tutti-attorno-al-fuoco. Il problema, mi hanno spiegato, non era banale perché i teatri sono di due tipi: ci sono quelli lunghi e stretti con un grande schermo dietro il palco per rimandare le immagini alle ultime file che sono lontanissime dall’oratore; oppure ci sono quelli circolari, shekspiriani, ma senza spazio per lo schermo, che invece in un TED è essenziale per mostrare video e primi piani. Rockwell ha progettato un teatro circolare ma con uno schermo dietro il palco di trenta metri. Mai visto prima. Lo ha progettato e realizzato su misura assemblando ottomila e 800 pezzi di legno, uno diverso dall’altro, che dopo la conferenza vengono smontati e tenuti in un container fino all’anno seguente.

Il risultato finale è mozzafiato. Questo gigantesco teatro di legno quando ci metti piede ti sembra un’Arca di Noé che deve portarti in un mondo migliore. Il diluvio fuori c’è e dentro non fanno che dirtelo. Ma quest’anno deve aver sbagliato rotta, visti i risultati. Che tirasse un’aria complicata per gli ottimisti a buon mercato Chris Anderson lo ha aveva intuito dalla fine del 2016 almeno: ci eravamo sentiti al telefono per una intervista e non c’era bisogno di attendere la vittoria di Trump per capire che il mondo migliore non era esattamente dietro l’angolo.
Lo dissi ad Anderson e ricordo di averlo sentito per la prima volta esitante: era chiaro che lo storytelling andava aggiornato. E così il titolo di quest’anno, The Age of Amazing, l’Età della Meraviglia, scelto puntando tutto sul sostantivo più usato sul palco, quello con il quale vengono commentati quasi tutti gli interventi, “Amazing! Amazing!”, è diventato bifronte: “La meraviglia può essere di due tipi” ci aveva detto Anderson qualche giorno prima in un briefing telefonico con la stampa mondiale: “C’è la meraviglia per una cosa bellissima e quella per una cosa spaventosa”. Spazio anche alla paura allora. Del resto le cose spaventose non mancano se pensiamo che il 34 esimo TED si è svolto nella settimana in cui Zuckerberg è stato “grigliato” dal Congresso americano mettendo in luce il lato oscuro della rete; mentre il presidente degli Stati Uniti con un tweet informava il mondo che sulla Siria sarebbero arrivati dei missili “nuovo, simpatici e intelligenti”. Anche un po’ “amazing” avrebbero detto dal palco del TED.

In realtà Anderson, nonostante l’apertura alle paure dell’umanità, resta un ottimista convinto. Ha vacillato anche lui, si capisce, ha tentennato, lo ha detto, ma poi è uscito un libro che ha rimesso le cose a posto. Un po’ come la Bibbia. Il libro di Steven Pinker. Si chiama Enlightenment Now, Illuminismo Oggi, ed è un lunghissimo, dettagliatissimo, informatissimo, a tratti noiosissimo trattato sul perché viviamo nel migliore dei mondi possibili. Se vi ricorda il Candido di Voltaire non vi sbagliate. Va detto che è da qualche anno che Pinker sostiene questa tesi ma Enlightenment Now punta a dire la parola fine sul tema. È un libro informatissimo perché parte dai dati, dai numeri. Quelli di alcuni blog – uno in particolare, ourworldindata, di Max Roser, davvero imperdibile - dove si mettono assieme statistiche di lunghissimo periodo. Tipo: l’aspettativa di vita dal ‘700 ad oggi, la mortalità infantile dall’800, la povertà dal ‘900.
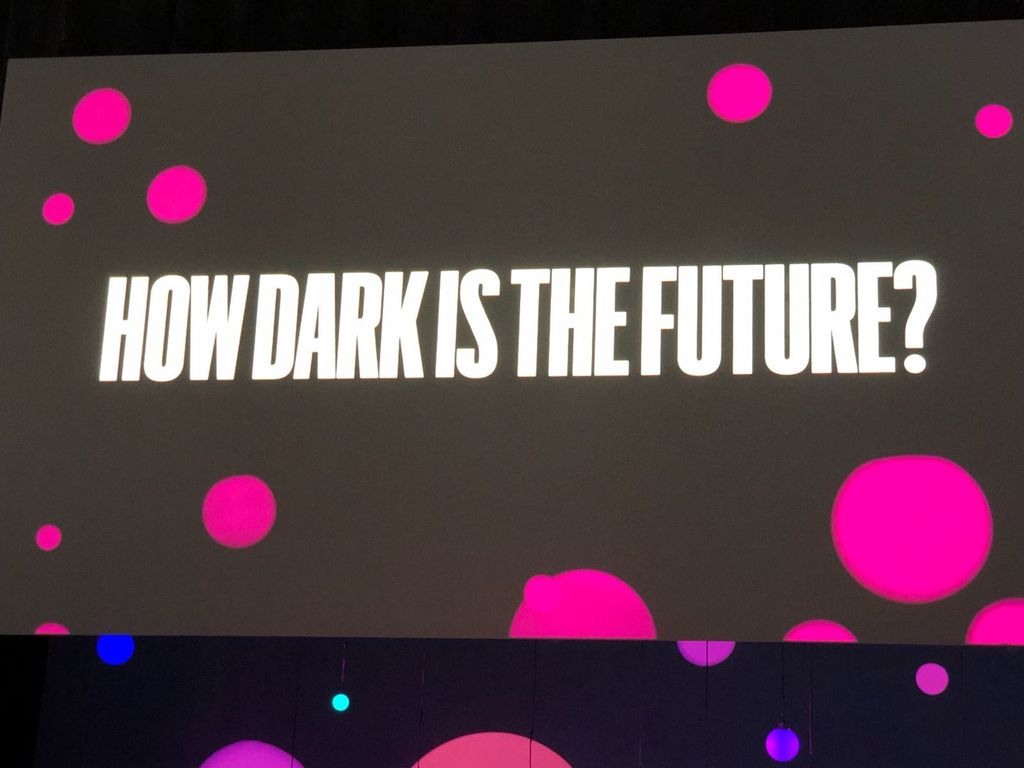
Ecco, visti nella prospettiva dei secoli e non degli anni, tutti o quasi i problemi del mondo appaiono in via di soluzione se non già quasi risolti. Viviamo molto più a lungo di prima, in condizioni molto migliori e con molte più comodità. Evviva. “E’ un fatto, se le persone non lo sanno è perché non sono informate bene” dice Pinker che qui viene su un terreno che mi riguarda: il ruolo di chi per mestiere produce informazione, i giornalisti. Dice Pinker che i giornali sono costruiti su questo semplice assunto: “Qual è la notizia terribile da mettere in prima pagina oggi?”. Ogni giorno ce n’è almeno una ovviamente, mentre le cose che contano davvero, quei trend di lungo periodo che ci dicono che il mondo sta davvero sempre meglio, non diventano mai notizia e quindi le persone lo ignorano e giorno dopo giorno cambiano. Diventano pessimisti.

“La narrativa del declino fa parte della natura stesso del giornalismo” ha provato ad argomentare Pinker “se un fenomeno negativo cala per cento anni, per esempio gli omicidi, e un anno registra una piccolissima ripresa, è solo quella ripresa che fa notizia”. E questo non è bello né giusto. Pinker lo ha detto in un lungo incontro intitolato in pieno spirito del tempo “How Dark is the Future, quanto è nero il futuro” e moderato da Anderson. Un’ora e mezza da solo due giorni dopo il talk di apertura: “È una eccezione, non lo facciamo mai ma questo libro è troppo importante” si è giustificato Anderson, ma bastava che dicesse che qualche mese fa ha regalato una copia del libro di Pinker a ciascun membro del suo staff e avremmo capito. Quel libro non è un libro, è un antidoto al pessimismo, andrebbe letto ogni giorno con costanza come si prende una pasticca antidepressiva. Tanto entusiasmo è tutt’altro che isolato se anche Bill Gates lo ha voluto recensire personalmente dicendo che “è il miglior libro mai letto” in tutta la sua vita. Sono cose.

Ma nonostante questi endorsement la discussione è apertissima come si è visto al TED. A un certo punto uno gli ha chiesto: insomma, è colpa dei giornalisti, professor Pinker, se l’ottimismo è finito in cantina? “Io non sto difendendo le ragioni dell’ottimismo, ma semplicemente voglio dimostrare che il declino non esiste, è una illusione, le persone dovrebbero saperlo”. A nostra insaputa, insomma, siamo in una nuova Età dei Lumi, altro che Età della Meraviglia Spaventosa. E pazienza se dopo l’Illuminismo è arrivata la Rivoluzione Francese con le teste mozzate e Napoleone si è proclamato imperatore del mondo (e in giro di aspiranti Napoleoni se ne vedono più di un paio). Tutto va bene, anzi benissimo nel favoloso mondo di Pinker.

Ma al TED per la verità stavolta non si sentiva, anzi per la prima volta sentivi urgenti i problemi del mondo. Le ingiustizie, le contraddizioni, la mancanza di soluzioni facili e persino la diffidenza verso la tecnologia e verso la rete, un tempo viste come la terra promessa che avrebbe creato automaticamente un’umanità migliore. Uno storytelling ormai finito, possiamo dirlo, ora che il TED 2018 si è concluso.
Il primo giorno, il 10 aprile, un’oretta prima di Pinker, che ovviamente aveva avuto l’onore dalla conclusione della giornata, era intervenuto Jaron Lanier che con i lunghissimi capelli ricci su un corpaccione monumentale è anche fisicamente il tipico esponente della controcultura californiana, quelli che pensavano che la rete avrebbe creato un mondo libero e si sono ritrovati con Google e Facebook a vendere i nostri dati. Lui queste cose le dice, anche al TED, da anni, ci ha fatto conferenze e libri per avvertirci che “se un prodotto è gratis, il prodotto sei tu”.
Lo diceva e nessuno se lo filava. Che noia, dateci un ottimista. Stavolta ha parlato, ha detto che la rete è rotta e va aggiustata e che non possono farlo quelli che l’hanno rotta (“un tragico, assurdo, ridicolo errore”); e ha aggiunto che un giorno pagheremo per avere un motore di ricerca efficiente e un social network adeguato, pagheremo e sarà meglio di adesso perché non è accettabile che se due persone devono comunicare c’è un terzo che ci guadagna spiandoli.
Lanier insomma ha fatto Lanier: ma stavolta niente spallucce, stavolta è venuto giù il teatro dagli applausi (qui c’è l’abitudine della standing ovation se uno speaker è molto apprezzato); e il primo talk ad andare in rete (un onore accordato solo ai più apprezzati) è stato il suo. Titolo: “How we need to remake the Internet”, 15 minuti scarsi, già 300 mila views in tre giorni, andrà lontano stavolta Jaron, così come il libro di prossima uscita, “Dieci ragioni per uscire da tutti i social network. Adesso”.
In realtà raccontato così sembra che il TED sia stato una palla e invece è stata nonostante tutto una festa. La solita festa. Del resto è una settimana molto costosa per chi vuole partecipare, diciamo mille dollari al giorno fra una cosa e l’altra, e va bene che l’ottimismo è temporaneamente perduto, ma il divertimento e una certa stravaganza no, quella è compresa nel prezzo. E quindi se sul palco il clima era a tratti cupo, tendente al depresso (l’apice si è toccato giovedì sera quando la conclusione è stata affidata ad un cantante straziante che dopo la prima canzone ha detto con convinzione “io amo la depressione”); fuori era il solito luna park che mescolava futuro prossimo, buone intenzioni e demo di prodotti incredibili. Nulla è lasciato al caso. Nulla. Per dire, il cibo. Non è cibo. La barretta proteica è distribuita con lo slogan “mangiala, salverà il mondo” (nel senso che per ogni barretta si impegnano a dare un pasto a bambini affamati); nei frigoriferi sparsi trovavi una bottiglietta di Brain Gear, un liquido che aiuta memoria e brillantezza mentale (in realtà è un mix di succo di ananas e mango, ne ho bevuti litri, chissà che non mi aiuti sulla memoria); se volevi l’acqua dovevi cercare “una stazione di idratazione”, cioè una fontanella ma dovevi portarti la borraccia vuota da casa perché la plastica distrugge il mondo.

In generale il cibo al TED deve rispettare tre requisiti: farti bene, fare bene al mondo ed essere innovativo. E quindi al buffet del pranzo, accanto ad ogni pietanza c’era un cartellino che ti diceva, questo è ricco di vitamina B12, questo ha il calcio, questo zabaione è vegano. Ma il massimo era il Food Lab, un angolo dove erano offerti vari tipi di cibi del futuro. Il Beyond Burger per esempio è il famoso hamburger vegetale ma che sa di carne e che però non inquina il pianeta perché appunto è vegetale. C’era ogni volta una tale fila per assaggiarlo che ho rinunciato. In compenso ho apprezzato gli ottimi mini-pancake fatti con uno scarto della farina che raccolgono nei mulini invece di buttarla; e soprattutto le orrende bevande salutiste fatte mischiando alghe, frutti, essenze, aromi. Hanno uno scopo ben preciso ovviamente: una favorisce la devozione (non la digestione!), una la resistenza, una la tenacia e una naturalmente l’innovazione. La formula di quest’ultimo dice tutto: H2o alcalino, clorofilla, e3 live (un’alga, mi hanno detto), succo di limone, miele grezzo e sale dell’Himalaya. Colore verde brillante. Ne ho presi due “shottini” oggi, se mi trovate diverso sapete il perché.

Il cibo non è tutto, ovviamente. Nei larghissimi viali all’interno del centro congressi durante il TED ci sono istallazioni di realtà virtuale che ti fanno sentire dentro Star Wars, robottini domestici e parlanti, stampanti di DNA sintetico (giuro!), test istantanei del tuo DNA per avere una dieta personalizzata (giuro di nuovo); sistemi per trasformare tutte le tue password in un DNA (questa non l’ho capita neanche io, proverò); e poi droni per scattarsi i selfie, e selfie per sembrare cloni, giochi e gadget di ogni tipo e naturalmente un classico di questi eventi, la combinazione di donne e motori. Solo che il motore è quello di una strepitosa auto elettrica da corsa di una grande casa automobilistica e le donne sono tre giovani violiniste molto rock che suonano con vigore notevole degli strani violini stampati in 3d.

Un circo, ma un gran bel circo va detto. Fuori è così divertente che a volte ti chiedi perché tutti facciano la fila per tornare dentro appena iniziano le sessioni di talk. Semplice, lo fanno perché ci credono. Credono alla favola del mondo migliore e hanno bisogno che qualcuno gliela racconti di nuovo. (“È vero che alla fine il drago perde? E’ vero figlia mia”, funziona così in fondo, è un meccanismo che viene da lontano). E il bello è che nonostante il momento, lo spirito del tempo e l’incredibile serie di cazzate fatte in Silicon Valley, per dirla alla Lanier, la favola resiste. Resiste perché ci sono ancora persone che fanno cose straordinarie. Ed è vero che non fanno notizia, è vero che devi venire fino al TED per scoprirli altrimenti non lo sapresti mai.
A me per esempio ha colpito il medico liberiano Rai Panjabi che ad Harvard ha creato una app per formare decine di migliaia di infermieri in Africa dove si muore per mancanza di semplici cure immediate. Oppure lo scienziato della Pennsylvania Aaswath Raman, che dopo essersi occupato di come riprogettare i campi profughi in Sierra Leone, ha lanciato una startup che promette di creare il freddo senza elettricità, semplicemente usando il grande freddo dello spazio “perché il sole è essenziale alla vita, ma anche il resto del cielo ha qualcosa da offrirci”. O Enric Sala che ha usato i satelliti per incastrare tutte le navi che vanno a pescare dove è vietato negli Oceani. E poi Floyd Romesberg che si è chiesto “perché il DNA deve essere limitato a sole 4 lettere (G, A, T e C)? Non ne posso fare uno di sei?” E ha iniziato a creare biomolecole artificiali che forse potranno curare malattie incurabili.
L’ultima immagine che ho è quella di una mia conoscenza di qualche anno fa, Hugh Herr, scienziato del MIT, con lo sguardo algido da attore alla 007 e due protesi alle gambe che ha perso drammaticamente in un incidente. Era il 2009 quando finì sulla copertina di Wired Italia, perché aveva trasformato una sua tragedia personale in una ossessione scientifica: come realizzare protesi migliori per tutti. A Vancouver è salito sul palco con disinvolta eleganza, ha accennato un paio di saltelli, ha fatto finta di iniziare a correre e poi ha raccontato una storia. La storia del team che ha creato al MIT, si chiama Team Cyborg, un team di persone che punta a creare protesi che non siano più solo protesi, ma integrazioni naturali del nostro corpo, potenziamenti inimmaginabili, la chiama “bionica personale”; e ha concluso con voce ferma, come se vedesse quello che stava dicendoci: “Presto con questa tecnologia gli uomini saranno come i supereroi, e potranno volare”.

Ce ne sarebbe abbastanza per tornare ottimisti e dare ragione a Pinker insomma. Va tutto bene, andrà tutto sempre meglio. Ma sarebbe sbagliato. Non è questo il messaggio del TED 2018. Il messaggio è quello che emerso dal talk di un giovane attore venezuelano, uno YouTuber diremmo noi, che ha parlano venerdì mattina. Ci arrivo, ma prima di lui c’è stato un altro intervento che ci ha fatto riflettere. Alle 8 e 30 sul tappeto rosso è salito il giovane James Bridle, presentato come artista e scrittore, pensavo che il suo sarebbe stato il solito intervento di alleggerimento per iniziare la giornata. E infatti ha esordito mostrando un video dove per sette minuti si vedono due mani che aprono ovetti di cioccolato con la sorpresa dentro. “Quel video è stato visto 30 milioni di volte e come quello ce ne sono altri 10 mila su YouTube”.

Poi ci ha fatto vedere come, sempre da YouTube, con la funzione “autoplay” che fa partire in automatico un altro video correlato, puoi partire con Peppa Pig e in sei o sette passaggi arrivi, non sai perché, a un video dove Topolino si masturba. Davvero nessuno sa perché, “ma se avete figli, teneteli lontani da YouTube”, ha detto. Ma più in generale ci ha messo in guardia dai tanti pericoli della rete, dalle contraddizioni evidenti, e ha concluso così tra applausi scroscianti: “Smettiamola di pensare alla tecnologia come ad una soluzione per tutti i problemi del mondo, e iniziamo a considerarla una guida per capire meglio chi siamo”. Anche Bridle ha un libro pronto, uscirà fra un mese. Si chiama “New Dark Age”, il Nuovo Medio Evo, con tanti saluti all’Illuminismo di Pinker.

Ma il podio più alto di questo TED 2018 va ad un altro intervento, quello che più di ogni altro forse ci può aiutare ad attraversare questa fase complicata. Lo ha pronunciato Dylan Marron, 29 anni, origini venezualane, attore dice la sua bio, ma è choaro che è molto di più. Qualche tempo ha creato una web serie per denunciare il fatto che nei film i neri hanno sempre parti dove parlano poco: l’ha chiamata Every Single Word, e in pratica prendeva un film e lo doppiava usando solo le battute pronunciate da attori neri. Un successone. Quando negli Stati Uniti si è aperto il caso su quale toilette pubblica debbano utilizzare i trans, lui, gay dichiarato, ha lanciato un’altra web serie, Seduto nel gabinetto con un trans, dove li intervistava nei gabinetti pubblici. Il Anche qui, il successo è stato immediato, ma accanto al successo sono arrivati gli haters, quelli che hanno iniziato a insultarlo e a minacciarlo in molti modi. E lui allora ha risposto con un’altra serie, stavolta un podcast, solo audio: People Who Hate Me, persone che mi odiano. In pratica ha telefonato a quelli che lo insultavano e ci ha parlato. Li ha fatti parlare e li ha ascoltati. E ce li ha fatti ascoltare. Scoprendo dove finiva la loro umanità e perché. Capendoli e facendosi capire. Mettendo in luce la brutalità del mondo e di certe conversazioni in rete, ma provando a indagare le cause per tentare delle soluzioni.
Sentire frammenti di quelle conversazioni è stato uno dei momenti più intensi del TED; assistere a come questo ragazzo evidentemente simpatico e bello invece di dire che va tutto bene e voltarsi dall’altra parte, ha scelto una strada difficile e coraggiosa per andare incontro ai problemi trovando un modo per non farsi travolgere, è stato illuminante.

Una delle frasi più potenti e condivise della settimana l’ha pronunciata Cesar Hidalgo, un giovane e brillante ricercatore del MIT. Ha detto: “I pessimisti hanno sempre un problema per ogni soluzione” (difendendo una sua proposta apparentemente davvero insensata per unire la democrazia diretta e l’intelligenza artificiale). È una bella frase, una frase da TED. Ma la frase che meglio riassume il momento che stiamo vivendo e che risponde alla domanda dove sono finiti gli ottimisti e perché sembriamo tutti infelici, quella frase non l’ha veramente detta nessuno con le parole che vi dirò, ma in un certo senso l’hanno ripetuta in tanti. La frase è: “Il mondo è più complicato del previsto, alcuni problemi sono molto seri e non esistono soluzioni semplici, ma con pazienza, studio ed empatia verso il prossimo è possibile trovare delle soluzioni sapendo che nel mondo c’è anche chi usa i nostri stessi strumenti per fare del male; ma se sapremo resistere, capire, imparare e se sapremo farlo con altri è possibile che alla fine ce la faremo”.
L'innovazione non è un pranzo di gala.
